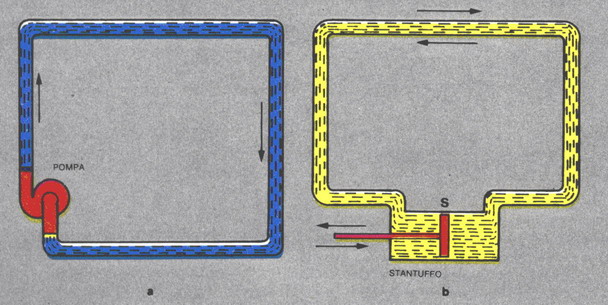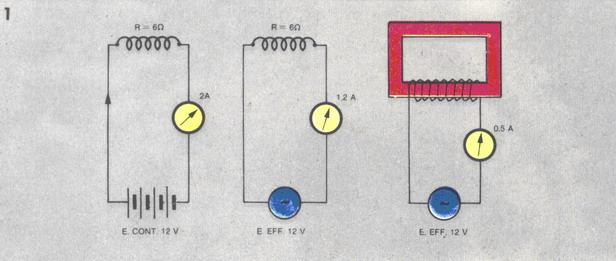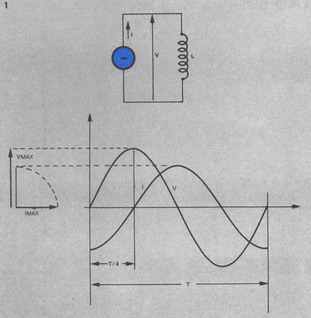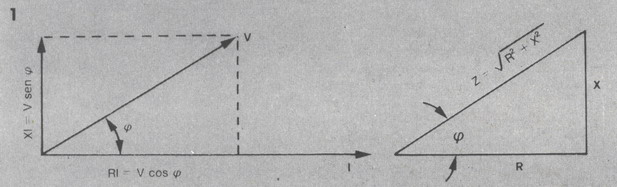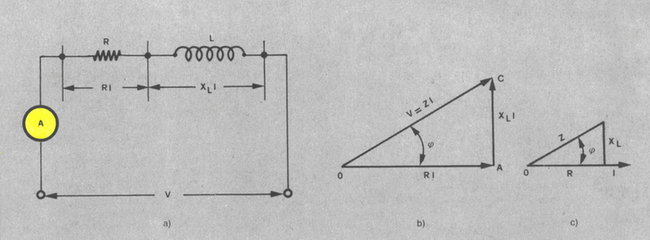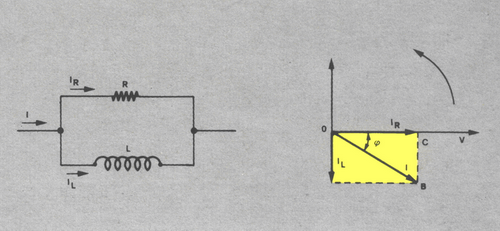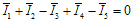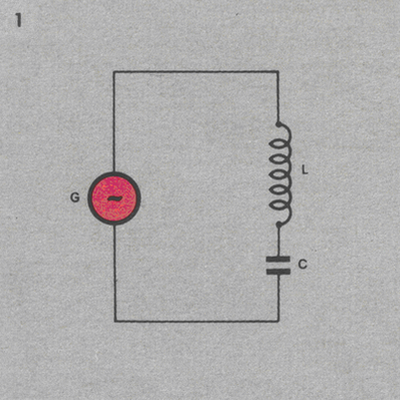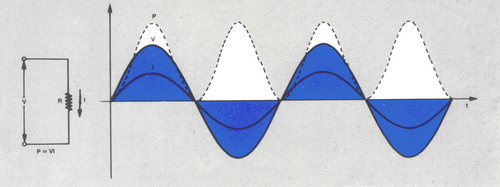Vai al contenuto
×





Megistone
Informazione senza limiti
CORSO DI ROBOTICA
IO, Robot

Dalle fondamenta alle strutture informatiche
Da Pascal a Shannon
Vedi lezioni
Eserciziario